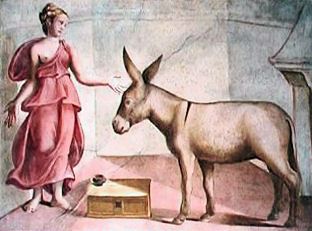di DANILO CARUSO
I mercati, le attività finanziarie e quelle produttive
attraversano ciclicamente nel sistema capitalista dei momenti critici di durata
variabile: accade che i prezzi aumentino, le vendite diminuiscano e la disoccupazione
aumenti.
Un
economista inglese vissuto tra ’700 e ’800 riteneva che la causa del disagio in
cui versasse la schiera dei diseredati risiedesse in loro, nel perpetuare
questa genia di disgraziati, e che i loro mali sarebbero terminati con loro
stessi.
La
moderna globalizzazione ha allargato pregi e difetti del capitalismo a livello
mondiale senza operare una generalizzazione del benessere collettivo (che già
non era perfetto nei paesi di provenienza). Sembra che la crisi attuale voglia
riproporre quel darwinismo sociale di Thomas Malthus nel tentativo di provocare
la soppressione di tutte quelle categorie umane che non dispongono di risorse
stabili per sopravvivere.
A partire dal “terzo mondo” milioni di individui soffrono a causa
della sperequazione dei beni prodotti. L’attività umana produttiva è alla base
del sostentamento, il lavoro ha una funzione centrale.
Questa funzione dovrebbe essere quella di produrre non mirando
alla ricerca di un guadagno anche attraverso le cose più inutili o dannose, ma
mirando a ottenere i mezzi per una quanto meno dignitosa esistenza nell’ottica
di contribuire, dall’imprenditore al lavoratore, alla tutela della prosperità
dell’intero insieme civile.
Le imprese private tengono in piedi l’apparato economico-sociale
per il fatto che da loro proviene la contribuzione tributaria più autentica. Il
servizio pubblico non sempre è pienamente efficiente e a volte è parassitario,
produce in alcuni casi meno di quello che dovrebbe o potrebbe: i dipendenti
pubblici sono retribuiti con soldi presi dalle imprese, e non c’è da stupirsi
che poi esista l’evasione fiscale di fronte a sprechi e gestioni clientelari
della ricchezza tributaria.
Il cattivo servizio pubblico è l’esempio di inutile e sterile produzione
con spreco di denaro, come inutile produzione è quella di imprese che mettono
sul mercato prodotti di nessuna utilità, o addirittura nocivi alla salute
umana, con l’induzione a comprarli per una questione di adeguamento a status-symbol.
La logica del profitto crea squilibrio sociale pure poiché la pressione
fiscale sulle imprese si ripercuote sui loro dipendenti: una maggiore tassazione
equivale a una riduzione dei lavoratori o dei loro stipendi.
È chiaro che non tutti i principi del liberismo siano
condivisibili sino ai loro estremi: uno che persegue il proprio interesse cerca
solo il suo bene e si serve degli altri con cui è costretto a condividere il
suo successo imprenditoriale (in passato c’erano gli schiavi cui bastava dare
il minimo necessario per sopravvivere); il mercato non è un organismo autonomo
che si regola da sé, è anch’esso un risultato delle attività dell’uomo.
Il recupero di un’economia sana avrebbe bisogno di riformare il
capitalismo sostituendo nei suoi principi alla logica del profitto e degli
interessi di parte la logica dell’utilità collettiva: sanità, trasporti, etc.
pubblici e privati così troverebbero contributori
ben disposti.
Nessuno è spontaneamente disposto ad acquistare servizi e prodotti
scadenti a meno che non sia raggirato.
La legislazione sul lavoro sarebbe migliorata se accogliesse altri
provvedimenti ispirati a canoni di giustizia sociale per difendere
un’equilibrata partizione del benessere globale.
a) Il primo sarebbe una legge sul diritto al lavoro che garantirebbe
a ogni nucleo familiare almeno una fonte di reddito, e che stabilirebbe la distribuzione
dei posti nel pubblico impiego secondo merito e secondo necessità (abolendo parzialmente
i concorsi).
b) Il secondo riguarderebbe la riforma dell’impresa privata.
A
capo ne rimarrebbe sempre l’ideatore (che solitamente è anche colui che investe
il capitale di rischio): una parte dello stipendio dei dipendenti dovrebbe
essere ancorata in percentuale ai guadagni complessivi: i lavoratori contribuiscono
all’eventuale fortuna economica e pare ipotesi naturale la loro partecipazione
ai dividendi così come il caso del giusto licenziamento.
c) Un terzo provvedimento sarebbe di carattere generale e fiscale
poiché statuirebbe il principio di imponibilità nei confronti dei soli redditi:
si concentrerebbe la tassazione unicamente sui guadagni sopprimendo le imposte
sulle cose che non abbiano prodotto denaro.
Non conviene allo Stato restare estraneo al gioco
economico-finanziario, anzi per i compiti di garanzia che assume è lecito che
ne prenda parte con discreta funzione di arbitro e di moderatore delle parti
qualora queste non siano in armonia. Privatizzare servizi importanti per
migliorarli è cosa contraddittoria: è lo Stato sussidiario, non il privato. I
pessimi servizi pubblici andrebbero perfezionati rimuovendo tutti i problemi.
Non sembra buono smantellare la macchina statale che funzioni male
mutilandola a favore di interessi particolari. Un’economia mista, in un regime
di libertà e di controllo, pare la più auspicabile.
Le partecipazioni statali mirate hanno impedito nei momenti di profonda
crisi che il sistema andasse in rovina.
Il capitalismo senza regole e senza limiti non ha senso ed è espressione
di irrazionalità: giunge sempre un momento in cui la produzione e la vendita
assumono una tendenza al ribasso poiché non si può produrre per vendere indefinitamente.
La massima ambizione del capitalista è il profitto infinito a svantaggio
di tutto e di tutti.
Un’economia che al criterio del profitto sostituisse quello della
sussistenza del genere umano non produrrebbe l’inutile superfluo non commerciabile
che genera le crisi.
Il mondo del
lavoro intellettuale e manuale consente la sopravvivenza della civiltà: per ottenere
meglio questo fine è possibile lavorare tutti (e non far finta come capita in
alcune circostanze), lavorare meno pro capite (con acquisizione di maggiore
tempo libero), risolvere quindi il problema della disoccupazione e avere più ricchezza
da redistribuire (senza lasciare sacche di disagio).